II - Duarte arriva a Turda
da: I Racconti di Turda
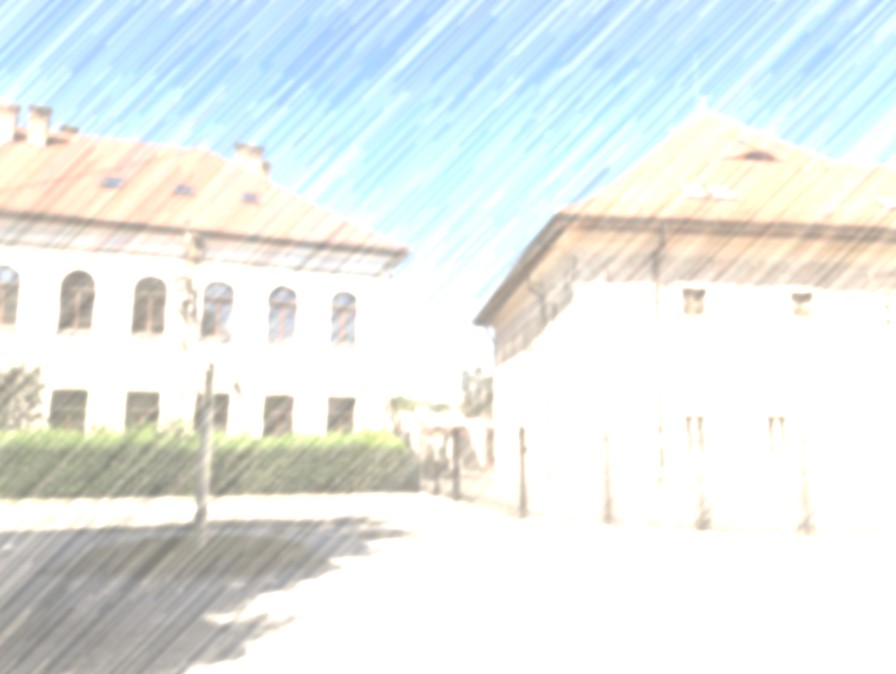
Duarte arriva a Turda
Questa è la prima memoria che ci giunge da Duarte. Non c'è, nel suo diario, una introduzione vera e propria al suo arrivo a Turda. Né riusciamo a sapere, solo da questo primo stralcio del suo diario, come lui sia arrivato al giardino di Ion Rațiu. In seguito, tuttavia, riusciremo a fare alcune deduzioni.
Duarte qui salta ogni preambolo; si lancia; si butta diretto nel rimuginio di tutto ciò che vede e che immagina; fa associazioni di idee senza mediazione. Duarte insomma prende le cose di petto. Per certi versi il suo inizio è aggressivo; per altri, gentile. D'altronde, possiamo capire da alcuni indizi che Duarte, al momento in cui inizia a scrivere, ha già girovagato un po' per la cittadina di Turda. Lo capiamo, per esempio, dal nome di un liceo ungherese che appare ad un tratto quasi inosservato, in mezzo al flusso delle sue impressioni; lo capiamo, anche, da un suo sguardo fugace rivolto alla vicina Basilica Ortodossa.
dal diario di Duarte: 29 agosto
A casa avevamo una serie di libri sulle storie di bambini emarginati, come il Libro Cuore. Confesso di non averlo mai letto, ma mio padre spesso lo citava. Era uno di quei libri che ti rimangono nell'animo, così come era rimasto a lui.
Insieme al Libro Cuore, mio padre parlava anche di un altro romanzo con la stessa passione: si trattava di un certo "Incompreso" (era proprio quello il titolo: incompreso. Non era un aggettivo che doveva caratterizzare mio padre, né un aggettivo del romanzo). Anzi, forse mio padre parlava di questo Incompreso con una passione persino maggiore di quella che dimostrava per Cuore; ma poi, una sfuggente inclinazione nella voce tradiva la sua preferenza segreta, e io già avevo capito da tempo che Cuore, alla fine di tutto, usciva vittorioso su Incompreso. In ogni modo, quei due romanzi erano stati entrambi scritti per persone sensibili (e naturalmente erano stati scritti da persone sensibili), perché mio padre aveva un certo non so ché di sognante, di etereo negli occhi vitrei, lucidi, quasi bagnati da un incipit di lacrime che poi non si producevano mai in realtà, ma restavano a mezz'aria, nell'immaginazione di chi gli vedeva il viso un po' assente, e chissà in quali riaffiorare di emozioni dell'età di bambino si trovava immerso (mio padre), sognando a naso in su di Cuore e di Incompreso, con un diafano accenno di malinconia sulle palpebre. Allora, quando arrivava a quel punto, lasciava perdere la troppa emozione nostalgica che ci soverchia quando ci volgiamo verso un passato reinventato, reinterpretato… un passato che non abbiamo mai vissuto e poi abbiamo come per incanto ritrovato sui libri…. (Avremmo potuto esserci noi in quel libro… riconosciamo quasi per caso). Allora, insomma, mio padre virava l'argomento su La luna e sei soldi, di Somerset Maugham. Era l'ultimo libro di cui gli piaceva chiacchierare. Anche questa faccenda della luna era la storia di un "diverso" comunque: una fuga fisica e spirituale dalla società dei normali e dei borghesi (però se ci si sente troppo emarginati, dico io, si può anche debordare verso la pazzia; anzi, è difficile evitarla, quando si arriva a un certo punto; e io non sapevo esattamente a che punto fosse arrivato mio padre).
Penso che se avessi letto anch'io il Libro Cuore, ora magari riuscirei a vedere il liceo di Turda qui vicino [Duarte siede a un caffè poco distante da questo liceo], il liceo teorico Yozcla Mizçlos, nel modo in cui mio padre vedeva la scuola dei bambini del libro. E ne saprei di più su Edmondo De Amicis. E ne saprei di più su mio padre.
[A questo punto Duarte comincia a divagare. Spesso lo ritroviamo, come dice uno dei tanti detti buffi che impariamo da bambini, saltare di palo in frasca. Duarte fa presto a distrarsi. A un certo punto magari nota una cosa che prima non aveva attirato la sua attenzione, e allora dimentica all'istante quello che sta scrivendo. Passa a parlare di quella cosa nuova che lo ha attratto, e mentre lo fa gli affiora qualche emozione, qualche ricordo sparso… e beninteso sente di dover parlare anche di quelli allora… Ma alla fine, in un modo o nell'altro, ritorna sempre all'ovile, per così dire; cioè: prima o poi riesce a riprendere il filo del discorso interrotto; o almeno, se non se ne sente più ispirato, riesce a chiuderlo]
Accanto al liceo teorico Yozcla Mizçlos c'è un palazzetto pieno di bei fregi. Mi piace: assomiglia tanto alla palazzina del liceo "Righi", quello dei tempi in cui andavo alle scuole superiori; quello all'imboccatura di viale Regina Margherita, dietro l'angolo dove andavamo a giocare a bowling, io e i compagni di scuola. Viale Regina Margherita era proprio un mondo verace, nei miei anni liceali, devo ammetterlo; direi che, di quegli anni, era una specie di "intorno matematico": uno spazio autoconsistente dove accadevano i miei eventi; dove si trovavano i miei oggetti; dove si ergevano i miei palazzi. Non le cose degli altri. Le mie. C'erano i bar nascosti a cui ero affezionato; c'erano gli archi di bugnato sotto le case; c'era la piazza quadrata controllata geometricamente dalla nostra professoressa di scienze. C'era via Po che portava al Parco dei Daini e alla Galleria Borghese, e il tram, che attraversava la via per intero, tutta, longitudinalmente.
Ma io stavo parlando dei romanzi, e mi sono distratto [ecco, come dicevamo, che Duarte riconosce di aver perso il filo del discorso, e si ridesta improvvisamente]. Le memorie di quei tre romanzi mi sono cadute addosso Improvvisamente, e non ne saprei bene il motivo: memorie di tre romanzi che mi paiono paradossalmente sprigionatesi dalla piazza della Basilica protestante qui di fronte, e che adesso sono volate via, e se c'era qualcos'altro da dire a questo punto non so cos'era. Forse queste tre memorie stavano cercando di dirmi qualcosa, così come l'inconscio dei sogni ci rivela le verità che non abbiamo messo a fuoco da svegli, e poi la psicoanalisi le mette in italiano...
Se c'è una verità da mettere a fuoco dietro i tre romanzi, dovrò aspettarla pazientemente, e d'altronde non ho fretta, perché qui a Turda io mi sento bene: ho una sensazione simile a quella che mi diede una volta Cabo de São Vicente, al limitare dell'Atlantico, poco fuori dalle Colonne d'Ercole, oltre le quali neanche l'ardito ed ingenuo Candide, avventuriero pronto a tutto per amore della sua bella Cunegonda, aveva avuto il coraggio di spingersi.
Ah: l'avventura! A me l'avventura piace, ma penso sempre che bisogna stare attenti a chi lo si confessa. Mia madre, per esempio, ha sempre connotato con un tono sprezzante gli avventurieri ("coloro che cercano l'emozione", parafrasa, e sempre mentre pronuncia "emozione" le si storce la bocca involontariamente, con un senso di schifo e di disapprovazione). "Cosa pretendono di trovare", domanda mia madre in tono di sfida, "quelli che puerilmente si illudono di sogni e di felicità nascosti dietro le fugaci voracità delle pulsioni bestiali?" (Lo so: mia madre avrebbe potuto essere una poetessa, ma non ha mai avuto la volontà e la costanza di scrivere ordinatamente e per bene). Questi avventurieri per lei mancano di una visione nella vita: di una razionale contestualizzazione dei momenti di felicità. I momenti di felicità dovrebbero essere normali alternanze ai momenti di noia, continua, filosofa d'occasione, a chiusura del suo sistema teoretico: "Non è questa dunque, l'essenza della vita normale??" (intende il non essere avventurieri e il non cercare ostinatamente e disordinatamente troppi momenti di felicità, ma appunto accontentarsi di quelli che si alternano alla noia).
Eppure, la storia è piena di avventurieri e di navigatori, che hanno sfidato le Colonne d'Ercole, l'Atlantico, e sono arrivati in America. Piena di Capitani Cook che imbarcavano biologi naturalisti, con l'eccitazione di dargli da catalogare piante e animali sconosciuti, una volta che fossero giunti sulle coste australiane. Qualcosa che muove questo motore umano c'è. Quelli come mia madre, io penso, sottovalutano la struttura biologica di Madre Natura. Certo è che mia madre ha, come tutti, una sua particolare struttura biologica, diversa da quella degli altri; e allora lo capisco che le riesca difficile saltare, come dire, su "un altro piatto di cellule"; cioè che le sia difficile immedesimarsi nella psiche di un altro essere umano. E perché poi dovrebbe farlo, dopotutto? Quegli uomini dannati dall'impulso del rischio (gli avventurieri) obbediscono a meri segnali che gli manda il loro gretto corpo. Non sono come lei e basta. Non c'è da sforzarsi ad immedesimarvisi. Per quegli uomini dannati, la morte diventa un ostacolo puramente secondario, quando lo confrontano con la prospettiva di soffrire invece, istante dopo istante, di quella che reputerebbero una vita inattiva. Quegli uomini non sanno reprimere i propri istinti, e gli istinti diventano i veri padroni della loro anima e del loro corpo. Poveri avventurieri condannati.
[A questo punto, Duarte si dimentica per qualche istante del discorso sulla famiglia (la madre, il padre…) e salta improvvisamente a un altro argomento. Succede quello che abbiamo accennato prima. Volge lo sguardo, fissa l'attenzione su una cosa, e si ricorda di qualcos'altro. A chi legge, Duarte quasi dà l'impressione di aver avuto un'amnesia: dov'è finito il discorso sulla madre e sul padre? E soprattutto come è finito!? Noi, curatori di questi suoi scritti sparsi, ci siamo abituati ai tagli bruschi. Come detto prima, più in là i fili si riannodano sempre, o quasi. È tutta questione di non aver fretta di sapere come va a finire. Intanto, per quel 29 agosto, Duarte non ha ancora terminato di scrivere. In ciò che segue, in un certo modo, tracce della famiglia ritornano, ma da un'altra direzione]